DESIDERARE IL MONDO – Linguaggi, corpi, icone. Dal 1 al 31 marzo 2021 un mese dedicato alla pluralità del femminile
Marzo: il mese delle donne. Un intreccio di incontri dedicati al desiderio di conoscenza necessario a interpretare il presente e ad affrontare la complessità del femminile. “Desiderare” è uno slancio di ricerca, di passione e volontà, perché il mondo è un luogo complesso da interpretare, da descrivere, da catalogare. Linguaggi, corpi e icone è il sottotitolo di questa esplorazione nel plurale femminile, lezioni, dialoghi e presentazioni editoriali su temi cruciali: lavoro, politica, scienza, maternità, malattia, società, cultura e ambiente, un programma multiforme, il cui filo rosso è lo slancio, spontanea propensione dell’animo femminile. Tante scrittrici per parlare di tutto questo.
GLI INCONTRI
Trasmessi online su Facebook, YouTube, circololettori.it
lunedì 1 mar
ore 18 | Sul carattere sociale della conoscenza scientifica

Perché fidarsi della scienza? (Bollati Boringhieri)
Naomi Oreskes con Silvia Bencivelli
Docente alla Harvard University, Naomi Oreskes costruisce una solida e avvincente difesa della scienza, mostrando in che modo il carattere sociale della conoscenza scientifica sia la sua forza più grande e la ragione migliore per darle fiducia. Per farlo parte proprio dai casi in cui gli scienziati si sono sbagliati, da errori lampanti – come la tesi sull’energia limitata delle donne (che non possono dedicarsi agli studi e all’istruzione superiore senza indebolire le proprie funzioni riproduttive) o l’eugenetica, tanto cara ai nazisti. Quando queste teorie, seppur errate, erano diffuse, esisteva comunque una comunità scientifica che non offriva il proprio consenso e metteva in evidenza aspetti ideologici e interessi nascosti. Ed è questo processo sociale a cui dobbiamo affidarci: non ai singoli scienziati – per quanto saggi o autorevoli -, ma allo scrutinio rigoroso e plurale che soggiace a ogni consenso scientifico condiviso.
il libro
I medici sanno davvero di cosa stanno parlando quando ci dicono che i vaccini sono sicuri? Dovremmo prendere in parola gli esperti del clima quando ci mettono in guardia sui pericoli del riscaldamento globale? Perché dovremmo credere agli scienziati quando i nostri politici non lo fanno? A partire da queste domande Naomi Oreskes costruisce una solida e avvincente difesa della scienza, mostrando in che modo il carattere sociale della conoscenza scientifica sia la sua forza più grande e la ragione migliore per darle fiducia. Ripercorrendo la storia e la filosofia della scienza degli ultimi due secoli, Oreskes mette in dubbio l’esistenza di un unico, aureo metodo scientifico, ma non rinuncia per questo a difendere la scienza dai suoi detrattori. La superiore affidabilità delle tesi scientifiche deriva, nella sua visione, dal processo sociale che le produce. Questo processo non è perfetto – niente lo è mai quando sono coinvolti gli esseri umani – ma Oreskes ci offre delle lezioni fondamentali proprio a partire dai casi in cui gli scienziati si sono sbagliati. È nel racconto di questi illuminanti «errori» che l’autrice ci accompagna in un viaggio appassionante tra alcune delle tesi più bizzarre e discutibili della storia della scienza: da quella dell’energia limitata, secondo la quale le donne non potevano dedicarsi agli studi e all’istruzione superiore senza indebolire le proprie funzioni riproduttive; a quella dell’eugenetica, i cui programmi statunitensi di inizio Novecento ispirarono la Germania nazista, promuovendo politiche che vennero interpretate come il coerente risvolto sociale della teoria darwiniana dell’evoluzione. Eppure, anche nei momenti di maggior diffusione di queste teorie, esisteva una comunità scientifica che non offriva il proprio consenso, e metteva in evidenza gli aspetti ideologici e gli interessi nascosti che si celavano dietro a quei risultati. Il punto è che la nostra fiducia non deve andare agli scienziati – per quanto saggi o autorevoli possano essere – ma alla scienza in quanto processo sociale, proprio perché garantisce il suo consenso solo dopo avere sottoposto le proprie tesi a uno scrutinio rigoroso e plurale.
mercoledì 3 marzo
ore 21 | Morire di linguaggio (in diretta su Instagram)

Stai zitta. E altre nove frasi che non vogliamo sentire più (Einaudi)
Michela Murgia con Vera Gheno
Tra le ingiustizie che le donne vivono e le parole che sentono esiste un legame mortificante: per ogni disparità di diritti che le donne subiscono esiste un impianto verbale che lo sostiene e lo giustifica. Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio. È una morte civile, ma non per questo fa meno male. È con le parole che si può sparire dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle notizie, nella vita quotidiana, come quando non si dice avvocata o architetta, altrimenti «dovremmo dire farmacisto». Quando fate un bel lavoro, ma vi chiedono prima se siete mamma. Quando siete le uniche di cui non si pronuncia mai il cognome, se non con un articolo determinativo davanti. Quando si mettono a spiegarvi qualcosa che sapete già perfettamente, quando vi dicono di calmarvi, di farvi una risata, di scopare di piú, di smetterla di spaventare gli uomini con le vostre opinioni, di sorridere piuttosto, e soprattutto di star zitta.
il libro
Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio. È una morte civile, ma non per questo fa meno male. È con le parole che ci fanno sparire dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle notizie, ma di parole ingiuste si muore anche nella vita quotidiana. Questo libro è uno strumento che evidenzia il legame mortificante che esiste tra le ingiustizie che viviamo e le parole che sentiamo.
Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la piú sovversiva. Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio. È una morte civile, ma non per questo fa meno male. È con le parole che ci fanno sparire dai luoghi pubblici, dalle professioni, dai dibattiti e dalle notizie, ma di parole ingiuste si muore anche nella vita quotidiana, dove il pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la nostra possibilità di essere pienamente noi stesse. Per ogni dislivello di diritti che le donne subiscono a causa del maschilismo esiste un impianto verbale che lo sostiene e lo giustifica. Accade ogni volta che rifiutano di chiamarvi avvocata, sindaca o architetta perché altrimenti «dovremmo dire anche farmacisto». Succede quando fate un bel lavoro, ma vi chiedono prima se siete mamma. Quando siete le uniche di cui non si pronuncia mai il cognome, se non con un articolo determinativo davanti. Quando si mettono a spiegarvi qualcosa che sapete già perfettamente, quando vi dicono di calmarvi, di farvi una risata, di scopare di piú, di smetterla di spaventare gli uomini con le vostre opinioni, di sorridere piuttosto, e soprattutto di star zitta. Questo libro è uno strumento che evidenzia il legame mortificante che esiste tra le ingiustizie che viviamo e le parole che sentiamo. Ha un’ambizione: che tra dieci anni una ragazza o un ragazzo, trovandolo su una bancarella, possa pensare sorridendo che per fortuna queste frasi non le dice più nessuno.
giovedì 4 marzo
ore 18 | Riscrivere il passato per difendersi dai ricordi

Esercizi di fiducia (SUR)
Susan Choi con Michela Marzano
e di Io amo leggere-Voci di donna con il contributo di Fondazione Cariplo
Esercizi di fiducia, National Book Award 2019, è una storia sui ricordi sfalsati, su quel meccanismo di difesa che ci porta a raccontarci un passato diverso da quello che effettivamente è stato, per difenderci dal dolore del vissuto, per nascondere ferite che comunque non andranno mai via. È la storia dell’amore fra due quindicenni, dei rapporti di potere tra studenti di una scuola di teatro e professori carismatici che usano in maniera subdola il loro potere, delle dinamiche malsane tra giovani donne e sedicenti intellettuali maschi. Diviso in tre parti, quanti i punti di vista dei protagonisti, racconta quell’imparzialità, a volte necessaria a volte ipocrita, dei ricordi, che nutre senza sosta l’attrito fra verità e finzione – nella letteratura, nella vita, nella memoria.
il libro
Sono gli anni Ottanta; David e Sarah, quindicenni, frequentano un’accademia d’arte drammatica e si sono appena innamorati; come molte storie adolescenziali, la loro sarà breve, intensa, piena di passione e di incomprensioni, esposta alle interferenze dei coetanei e degli adulti, fra cui il carismatico professor Kingsley. A distanza di quindici anni, un’ex compagna di scuola ripercorre gli eventi di quei mesi da un altro punto di vista, rivelando che ciò che ci è stato raccontato è solo una versione imperfetta e parziale dei fatti. E ancora più avanti nel tempo, con un ulteriore ribaltamento di prospettiva, scopriremo (forse) la dolorosa verità. Un romanzo a più voci che racconta l’amicizia, il desiderio, la fragilità e le ossessioni degli adolescenti, le dinamiche di sesso, potere e consenso, il delicatissimo rapporto fra insegnanti e allievi e l’attrito fra verità e finzione in ogni forma di racconto, dal teatro alla letteratura; appassionante e sorprendente, ricco di sottigliezza psicologica e colpi di scena, è l’opera che ha definitivamente consacrato presso critica e pubblico un’autrice già finalista al premio Pulitzer.

lunedì 8 marzo
ore 18.30 | Usare la matematica contro patriarcato, man-splaining e sessismo
X e Y. Una formula per risolvere i pregiudizi di genere (Ponte alle Grazie)
Eugenia Cheng con Claudio Bartocci
La matematica, da sempre, serve per immaginare cose che non vediamo nella realtà che ci circonda: i numeri irrazionali, la quarta dimensione, le radici quadrate. Perché, dunque, non metterla alla prova con la più inimmaginabile delle cose: la scomparsa del pregiudizio di genere. Attraverso la logica possiamo trovare un modo nuovo per parlare di patriarcato, man-splaining e sessismo. Ragionando con calma e precisione su questi argomenti che rendono il mondo un posto molto difficile per le donne, usando le statistiche e la deduzione, l’insiemistica e il sillogismo, Eugenia Cheng riesce a portare chiarezza dove invece c’è solo confusione, illuminare con originalità argomenti logori e porta un modo nuovo e liberatorio di pensare al mondo e al posto che le donne dovrebbero e vorrebbero occupare.
martedì 9 marzo
ore 18 | Whiteness: quando la solidarietà non basta

Bianchi (Solferino)
Otegha Uwagba con Francesco Costa
e di Io amo leggere-Voci di donna con il contributo di Fondazione Cariplo
Dopo l’uccisione di George Floyd, tutto il mondo è insorto, inondando le città di proteste e i social di sdegno. Ma tutto questo non basta, dice Otegha Uwagba. La vera svolta avverrà solo con quella che nel libro definisce allyship: per eliminare davvero il razzismo, cioè, i bianchi dovrebbero rinunciare per primi ai loro privilegi. La fondatrice della piattaforma Women Who, creata per mettere in connessione e supportare le donne lavoratrici di tutto il mondo, si rivolge non ai fanatici intolleranti, ma ai bianchi progressisti, illuminati, proprio quelli che hanno gridato allo scandalo. Per essere davvero alleati dei neri, devono rinunciare alla whiteness, rifiutare, tradire, negare dall’interno, un sistema che produce vantaggi a beneficio esclusivo dei bianchi. Sono disposti a pagare questo prezzo?
il libro
L’omicidio di George Floyd ha scosso il mondo. Ci ha messo di fronte alla realtà della relazione fra bianchi e Neri, con una violenza e un’immediatezza che ci fanno dire: ecco, la Storia si sta facendo adesso. Adesso, però, è anche il momento di dire la verità, di chiamare le cose con il loro nome. Otegha Uwagba, donna e Nera, dopo quei terribili mesi, sente di non dover fare nessuno sconto alla whiteness, intesa non come colore della pelle, ma come sistema di vantaggi imperniato sull’essere bianchi. I suoi interlocutori ideali non sono i fanatici intolleranti, ma i bianchi progressisti, illuminati, quelli che sembrerebbero ormai oltre la questione razziale. Quelli che, pur nutriti di buone letture e altrettanto buone intenzioni, non vedono ancora in faccia se stessi. Indignarsi o manifestare solidarietà li fa sentire «dalla parte dei buoni», ma non li rende alleati dei Neri. Sono solo all’inizio, benvenuti ma inefficienti, di un reale cambiamento. La vera alleanza prevede di abbandonare il caldo letto delle esternazioni in vista di un disconoscimento effettivo del privilegio implicito nella whiteness. Si spinge fino alla rinuncia della whiteness come fondamento di quel privilegio. Implica il rifiuto attivo di un sistema che produce vantaggi a beneficio esclusivo dei bianchi, il suo tradimento, la sua negazione dall’interno. Quei bianchi progressisti in piazza per George Floyd sono disposti a pagare questo prezzo? Un saggio provocatorio e illuminante, che parte dall’esperienza biografica dell’autrice e alza un velo sul non detto che sta al cuore dell’essere bianchi o Neri, oggi.
giovedì 11 marzo
ore 18 | Piccole grandi donne crescono

L’acqua del lago non è mai dolce (Bompiani)
Giulia Caminito con Gaia Manzini
Gaia è una ragazzina spaurita che vive in venti metri quadri con la mamma Antonia, il padre sulla sedia a rotelle per colpa di un incidente sul lavoro, il fratello maggiore e due gemelli più piccoli. Da corso Trieste a Roma, si trasferiscono, grazie alla tostissima madre, ad Anguillara, sul lago di Bracciano. Mentre Antonia mantiene la famiglia facendo le pulizie, Gaia prima alle medie, poi al liceo classico, reagisce ai torti subiti con violenza imprevedibile. Sono gli anni duemila, Gaia scopre l’amicizia e il senso di appartenenza, il tradimento e la delusione. Una storia di crescita, di cadute e riscatti impossibili in una Roma molto dura e realistica.
il libro
Odore di alghe limacciose e sabbia densa, odore di piume bagnate. È un antico cratere, ora pieno d’acqua: è il lago di Bracciano, dove approda, in fuga dall’indifferenza di Roma, la famiglia di Antonia, donna fiera fino alla testardaggine che da sola si occupa di un marito disabile e di quattro figli. Antonia è onestissima, Antonia non scende a compromessi, Antonia crede nel bene comune eppure vuole insegnare alla sua unica figlia femmina a contare solo sulla propria capacità di tenere alta la testa. E Gaia impara: a non lamentarsi, a salire ogni giorno su un regionale per andare a scuola, a leggere libri, a nascondere il telefonino in una scatola da scarpe, a tuffarsi nel lago anche se le correnti tirano verso il fondo. Sembra che questa ragazzina piena di lentiggini chini il capo: invece quando leva lo sguardo i suoi occhi hanno una luce nerissima. Ogni moto di ragionevolezza precipita dentro di lei come in quelle notti in cui corre a fari spenti nel buio in sella a un motorino. Alla banalità insapore della vita, a un torto subìto Gaia reagisce con violenza imprevedibile, con la determinazione di una divinità muta. Sono gli anni duemila, Gaia e i suoi amici crescono in un mondo dal quale le grandi battaglie politiche e civili sono lontane, vicino c’è solo il piccolo cabotaggio degli oggetti posseduti o negati, dei primi sms, le acque immobili di un’esistenza priva di orizzonti. Giulia Caminito dà vita a un romanzo ancorato nella realtà e insieme percorso da un’inquietudine radicale, che fa di una scrittura essenziale e misurata, spigolosa e poetica l’ultimo baluardo contro i fantasmi che incombono. Il lago è uno specchio magico: sul fondo, insieme al presepe sommerso, vediamo la giovinezza, la sua ostinata sfida all’infelicità.
lunedì 15 marzo
ore 18 | L’acqua: memoria e futuro, del Mondo e di tutti

Lettera tra due mari (Iperborea)
Siri Ranva Hjielm Jacobsen con Natascha Lusenti
L’acqua non è solo un insieme fluido, compatto, di gocce che scivolano e vanno, sfiorando terre, formando mari, oceani, universi sommersi. È memoria del Mondo e delle persone. È il passato e il futuro. È pur anche un elemento così fragile che, troppe volte dato per scontato, va protetto in ogni sua forma. Siri Ranva Hjielm Jacobsen, l’autrice di Isola, in questo racconto epistolare tra due sorelle, Acqua Atlantica e Acqua Mediterranea, rifonda il mito della grande madre e dà voce alle nostre acque, protagoniste dei cambiamenti climatici in corso sulla Terra, per raccontare la nascita e il declino dell’umanità.
il libro:
In principio il nostro pianeta era ricoperto da un’unica, felice distesa d’acqua, ma poi eruppe la terra, che squarciò la coltre primigenia separandola nelle tante sorelle chiamate oggi «mari» o «oceani» da noi umani, noi «creature». Da allora quelle sorelle, divise dalla terra ma anche dalla sensibilità e dal carattere di ciascuna, cospirano e mandano avanti un piano ingegnoso per sommergere tutto e tornare all’unità perduta. In una narrazione epistolare che ha la poesia e la tenerezza dell’intimità, Siri Ranva Hjelm Jacobsen rifonda il mito della grande madre e dà voce alle nostre acque, protagoniste dei cambiamenti climatici in corso sulla Terra, per raccontare la nascita e il declino dell’umanità.
lunedì 15 marzo
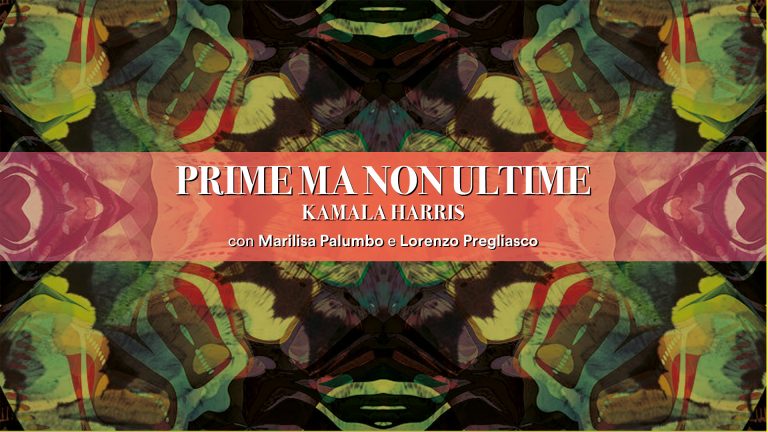
ore 21 | Prime ma non ultime #1
Kamala Harris
con Marilisa Palumbo vice caporedattore Esteri “Corriere della Sera”, Lorenzo Pregliasco
in collaborazione con YouTrend
«I may be the first, but I won’t be the last»: il 7 novembre 2020 la prima donna a diventare vicepresidente degli Stati Uniti salutava così la vittoria elettorale al fianco di Joe Biden. La storia e le battaglie di Kamala Harris – Attorney General in California, senatrice, candidata alla presidenza, vicepresidente – raccontano molto di come è cambiata la politica americana e di cosa aspettarsi dalla nuova Casa Bianca.
martedì 16 marzo

ore 18 | L’arte delle donne dal ‘900 a oggi #1
Le avanguardie storiche
con Luca Beatrice
Tra Futurismo, Dada e Surrealismo emergono nell’Europa del primo ‘900 figure davvero interessanti, provocatrici e sopra le righe. Presto si diffonderanno alcune icone dell’arte donna: Tamara de Lempicka, Frida Khalo, Carol Rama, Margherita Sarfatti.
martedì 16 marzo
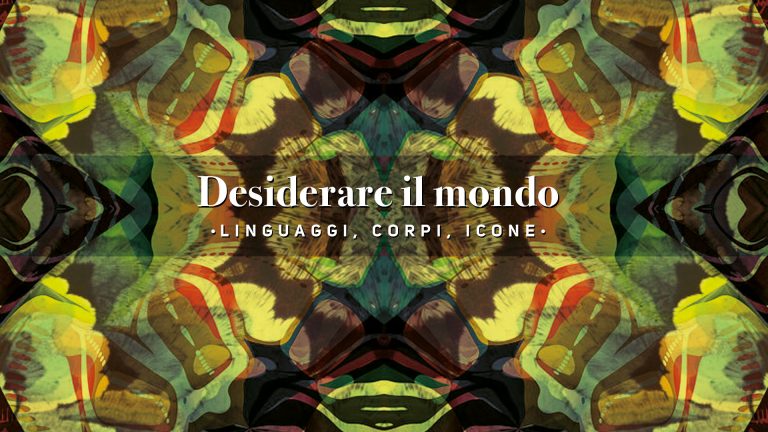
ore 21 | Le parole del dolore secondo Susan Sontag
Lettura da Malattia come metafora(Nottetempo) a cura di Giulia Muscatelli a seguire un dialogo tra Mario Calabresi ed Elena Loewenthal a partire da Davanti al dolore degli altri (Nottetempo), una riflessione sul dolore sia nella dimensione privata sia in quella pubblica.
Una serata dedicata a Susan Sontag attraverso la lettura e il commento delle sue opere.
i libri
Malattia come metafora e L’aids e le sue metafore (Nottetempo)
Un classico, ha scritto Italo Calvino, non ha mai finito di dire quel che ha da dire. Cosa ci dicono, oggi, questi due saggi di Susan Sontag, intensissimi e intrepidi come da sua cifra, pubblicati per la prima volta nel 1978 e nel 1989? Che la malattia, nonostante l’illusione di oggettività che l’Occidente “scientifico” tende a coltivare, non è percepita né concepita secondo le sue coordinate reali, ma è una costruzione culturale, profondamente connotata in senso metaforico. La malattia non parla di se stessa, perché la facciamo sempre parlare di altro, attraverso il linguaggio figurato con cui la bardiamo nella comunicazione e nell’immaginazione. E poiché “è quasi impossibile prendere residenza nel regno dei malati senza lasciarsi influenzare dalle sinistre metafore architettate per descriverne il paesaggio”, è in primo luogo ai malati che dobbiamo una resistenza e una liberazione dal cascame di queste metafore, particolarmente pericolose nel caso di malattie epocali, mitizzate (e mistificate) come “predatori malvagi e invincibili”: il cancro e le epidemie infettive (peste, tbc, sifilide, Aids, e altre che potremmo aggiungere a partire dal presente). “Nel tentativo di comprendere il male ‘radicale’ o ‘assoluto’, andiamo alla ricerca di metafore adeguate”, ma è solo togliendo potere a queste appropriazioni retoriche, afferma Sontag, che possiamo conoscere piú a fondo la realtà della malattia e affrontarla con la necessaria consapevolezza.
Davanti al dolore degli altri (Nottetempo)
Le sofferenze della guerra e l’orrore della morte si stampano nella mente attraverso immagini che lasciano un’impronta ostinata: dai cadaveri dei soldati della Guerra Civile Americana fotografati da Alexander Gardner alla celeberrima Morte di un miliziano repubblicano di Robert Capa, dalla bandiera usa a Iwo Jima ai bambini vietnamiti bruciati dal napalm, dalle foto dei lager nazisti nel gennaio del ’45 a quelle del campo di Omarska in Bosnia, per arrivare fino alle rovine di Ground Zero. Susan Sontag parla, a questo proposito, dello “shock” della rappresentazione fotografica, che ci mette in modo autoritario e immediato davanti al dolore degli altri. Esaminando la cavalcata di questo shock nel corso del tempo, l’autrice arriva a un nodo cruciale della nostra contemporaneità: malgrado la complessità e l’instabilità dei concetti di realtà/riproduzione, memoria/oblio pubblico, visibilità/invisibilità, il “valore etico” delle immagini di sofferenza che ci investono – a volte fino all’ipersaturazione – rimane intatto. E rimangono le domande che percorrono stringenti le pagine di questo libro: cosa succede davanti alla rappresentazione del dolore degli altri? È possibile una “riproduzione” del dolore? Come si può fotografarlo o filmarlo senza sottrargli verità o produrre effetti di voyeurismo? E, piú alla radice, chi è l’altro, quell’emblema perturbante che ci interpella dalla sua riproduzione? Ecco perché questo libro, pubblicato nel 2003, è ancora ricco di spinta e incisività, oltre a restare un irriducibile atto d’accusa contro la violenza: “nessuno può pensare e al tempo stesso colpire un altro essere vivente”.
mercoledì 17 marzo
ore 18 | Tre racconti sui prodigi dell’animo umano

Sortilegi (Bompiani)
Bianca Pitzorno con Alessandro Mezzena Lona
Bianca Pitzorno attinge alla realtà storica per scrivere tre racconti che sono percorsi dal filo di un sortilegio. Porta lontano nel tempo e nello spazio, restituisce il sapore di parole e pratiche remote – l’italiano secentesco, le procedure di affidamento di un orfano nella Sardegna aragonese, una ricetta segreta – e come nelle fiabe antiche osa dire la verità: l’incantesimo più potente e meraviglioso, nel bene e nel male, è quello prodotto dalla mente umana.
il libro
Mentre infuria la peste del Seicento, una bambina cresce in totale solitudine nel cuore di un bosco e a sedici anni è così bella e selvatica da sembrare una strega e far divampare il fuoco della superstizione. Un uomo si innamora delle orme lasciate sulla sabbia da piedi leggeri e una donna delusa scaglia una terribile maledizione. Il profumo di biscotti impalpabili come il vento fa imbizzarrire i cavalli argentini nelle notti di luna. Bianca Pitzorno attinge alla realtà storica per scrivere tre racconti che sono percorsi dal filo di un sortilegio. Ci porta lontano nel tempo e nello spazio, ci restituisce il sapore di parole e pratiche remote – l’italiano secentesco, le procedure di affidamento di un orfano nella Sardegna aragonese, una ricetta segreta – e come nelle fiabe antiche osa dirci la verità: l’incantesimo più potente e meraviglioso, nel bene e nel male, è quello prodotto dalla mente umana. I personaggi di Bianca Pitzorno sono da sempre creature che rifiutano di adeguarsi al proprio tempo, che rivendicano il diritto a non essere rinchiuse nella gabbia di una categoria, di un comportamento “adeguato”, e che sono pronte a vivere fino in fondo le conseguenze della propria unicità. Così le protagoniste e i protagonisti di queste pagine ci fanno sognare e ci parlano di noi, delle nostre paure, delle nostre meschinità, del potere misterioso e fantastico delle parole, che possono uccidere o salvare.
mercoledì 17 marzo

ore 21 | Del diritto al non amore
Odio gli uomini (Garzanti)
Pauline Harmange con Annalena Benini
Le donne sono state spesso accusate di odiare gli uomini. E istintivamente lo hanno sempre negato, a ogni costo. E se invece non credere agli uomini, disprezzarli, e perché no, persino odiarli, fosse una risposta utile al sessismo dilagante? Se questa reazione offrisse una possibile via di uscita dall’oppressione, e desse inizio a una forma di resistenza? Forse, proprio odiando gli uomini, si potrà essere finalmente libere, lontane dagli sguardi degli uomini e dalle esigenze maschili. In questo saggio tanto provocatorio quanto urgente, Pauline Harmange lancia un grido di battaglia per le donne di ogni luogo e di tutte le età.
giovedì 18 marzo

ore 18 | Lettera d’amore a una madre adottiva
Splendi come vita (Ponte alle Grazie)
Maria Grazia Calandrone con Sonia Bergamasco
Questa è la storia vera del tormentato rapporto fra l’autrice e la donna che l’ha adottata. Maria Grazia Calandrone ha 8 mesi quando viene trovata da sola a Villa Borghese: la sua vera madre si è appena suicidata buttandosi nel Tevere. La accolgono in famiglia Giacomo Calandrone, che da operaio metallurgico diventerà dirigente del Partito Comunista e siederà alla Camera per 10 anni, e sua moglie Iole. Dopo pochi anni Giacomo muore, Maria Grazia, che ha solo 11 anni ma sa già da tempo di essere stata adottata, rimane sola con quella che chiama Madre. Così racconta questo suo libro: «È il racconto di una incolpevole caduta nel Disamore, dunque di una cacciata, di un paradiso perduto. Non è la storia di un disamore, ma la storia di una perdita. Chi scrive è una bambina adottata, che ama immensamente la propria madre. Poi c’è una ferita primaria e la madre non crede più all’amore della figlia. Frattura su frattura, equivoco su equivoco, si arriva a una distanza siderale fra le due, a un quotidiano dolore, a un quotidiano rifiuto, fino alla catarsi delle ultime pagine. Chi scrive rivede oggi la madre con gli occhi di una donna adulta, non più solo come la propria madre, ma come una donna a sua volta adulta, con la sua storia e i suoi propri dolori e gioie. Quando si smette di vedere la propria madre esclusivamente come la propria madre, la si può finalmente “vedere” come essere separato, autonomo e, per ciò, tanto più amabile.»
lunedì 22 marzo
ore 18 | Il doppio cromosoma X femminile è superiore, lo dice la scienza

La metà migliore (UTET)
Sharon Moalem
Le donne combattono meglio degli uomini virus, infezioni e tumori; a parità di condizioni critiche hanno più possibilità di sopravvivere rispetto ai maschi; statisticamente sembrano superare di almeno quattro anni le aspettative di vita di un uomo e vedono persino il mondo in uno spettro di colori più ampio. Le donne sono meglio degli uomini, dunque? Sharon Moalem, medico genetista di fama internazionale, argomenta questa tesi attraverso l’analisi di pubblicazioni specialistiche ed esperienze personali e ne individua il fondamento scientifico nel codice genetico, più precisamente nel doppio cromosoma X femminile. Sono alcuni dei geni presenti su questo cromosoma ad attivare i processi di guarigione e a garantire dunque alla donna maggiore resilienza.
il libro
Le donne combattono meglio degli uomini virus, infezioni e tumori; a parità di condizioni critiche hanno più possibilità di sopravvivere rispetto ai maschi; statisticamente sembrano superare di almeno quattro anni le aspettative di vita di un uomo e vedono persino il mondo in uno spettro di colori più ampio. Le donne sono meglio degli uomini, dunque? Non si tratta di una semplice generalizzazione ideologica. Sharon Moalem, medico genetista di fama internazionale, argomenta questa tesi attraverso l’analisi di pubblicazioni specialistiche ed esperienze personali – nei reparti di neonatologia, tra bambini sieropositivi o attraverso l’attività di ricerca neurologica sugli anziani – e ne individua il fondamento scientifico nel nostro codice genetico: più precisamente, nel doppio cromosoma X femminile. Sono alcuni dei geni presenti su questo cromosoma, infatti, ad attivare i processi di guarigione e a garantire dunque alla donna maggiore resilienza: come afferma Moalem, infatti, «quasi tutto ciò che è difficile da fare, dal punto di vista biologico, è fatto meglio dalle donne». In nome di uno stereotipo legato alla forza fisica, invece, per secoli la donna è stata confinata nell’angolo del focolare domestico, ne è stata esaltata la fragilità e la delicatezza, le è stata destinata una posizione ancillare. Un luogo comune a cui ha aderito anche la scienza medica. Tuttora le differenze genetiche sono ignorate in nome della visione maschiocentrica dominante, e le donne vengono inquadrate attraverso l’obiettivo degli uomini: per esempio, molti degli studi preliminari sulle malattie sono compiuti esclusivamente su campioni di sesso maschile, contribuendo alla costruzione di una dottrina parziale, incapace di tenere conto delle specificità del nostro patrimonio genetico. Oggi sembra arrivato il momento di cambiare questa concezione monolitica della medicina e ribaltare le nostre credenze sul “sesso debole”: è tempo di riconoscere finalmente la metà migliore del genere umano.
lunedì 22 marzo
ore 21 | Prime ma non ultime #2
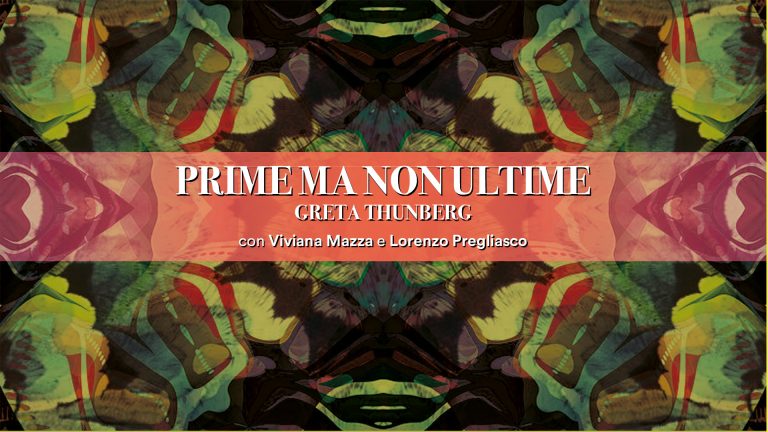
Greta Thunberg
con Viviana Mazza, giornalista “Corriere della Sera” e autrice di Greta. La ragazza che sta cambiando il mondo (Mondadori) e Lorenzo Pregliasco
in collaborazione con YouTrend
Può una ragazza di 16 anni cambiare il mondo in cui viviamo? La storia di Greta Thunberg, animatrice degli scioperi per il clima e del movimento globale Fridays for Future, permette di rispondere a domande non solo sull’ambiente e sull’emergenza climatica, ma anche sulla partecipazione civile e sociale di milioni di giovani in tutto il pianeta, sul ruolo dei social media nel rappresentare istanze ai decisori politici e su quanto ogni rivoluzione inizi, in fondo, con piccoli atti di coraggio.
martedì 23 marzo

ore 18 | L’arte delle donne dal ‘900 a oggi #2
Il femminismo e la Body Art
con Luca Beatrice
Gli anni ’70 segnano il cambiamento più significativo. Trasgressive, irriverenti, geniali provocatrici, le donne conquistano la scena proponendo il loro corpo, non più oggetto di rappresentazione ma soggetto attivo. Qui si parla di Yayoi Kusama, Marina Abramovic, Gina Pane, Ana Mendieta, del femminismo italiano e di altro ancora. Con un omaggio doveroso a Lea Vergine.
martedì 23 marzo
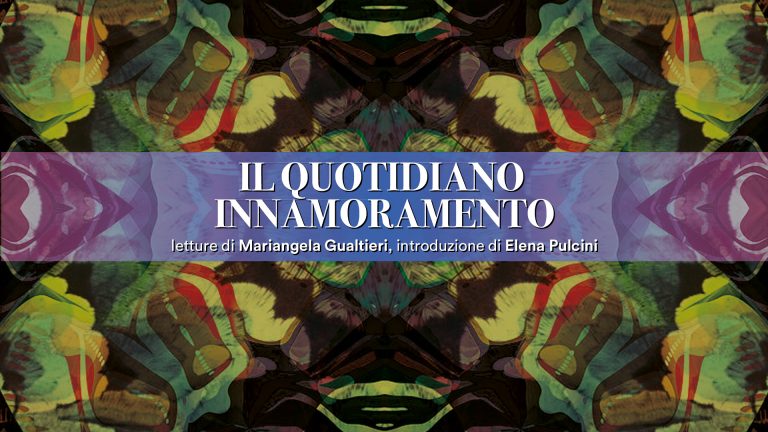
ore 21 | Maneggiare con cura
Il quotidiano innamoramento
letture di Mariangela Gualtieri
Dobbiamo trattare con gentilezza di spirito e di azione il nostro io interiore, chi ci sta simpatico e chi, invece, non capiremo mai, anche e soprattutto se non lo capiremo mai. La cura non è egoismo, né altruismo, è una disposizione d’animo necessaria per poter vivere, da soli e con le persone. È il paradigma dell’amore assoluto, quello che parte dall’osservazione (“cura” deriva dalla radice ku-/kav- “osservare”) e diventa responsabilità. Mariangela Gualtieri ci dedica la lettura di alcune sue poesie (soprattutto dall’ultima raccolta Einaudi Quando non morivo) dedicate proprio a ciò che nutre la cura.
giovedì 25 marzo (Dantedì)
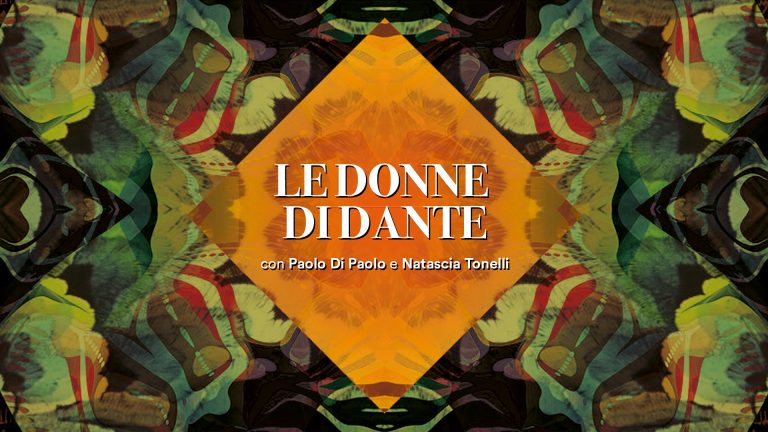
ore 18 | Beatrice e le altre
Le donne di Dante (Il Mulino)
a partire dal libro di Marco Santagata
con Paolo Di Paolo e Natascia Tonelli
Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri
Beatrice è di certo la più famosa, la Bice Portinari che Dante, conosciuta ancora bambina, trasfigura nella Vita Nova e nel Convivio e angelica nella Divina Commedia. Ma nella vita del Sommo ce ne sono state molte altre: dalla madre Bella alla moglie Gemma Donati alla figlia Antonia, che si farà monaca col nome di Beatrice e poi le dame e le gentildonne del tempo, come Francesca da Rimini e Pia de’ Tolomei, che pure trovano voce nelle cantiche della Commedia. A 700 anni dalla morte di Dante, nella prima edizione del Dantedì (ricorrenza recentemente istituita dal Governo proprio nel giorno in cui – il 25 marzo, appunto -, secondo gli studiosi inizia il viaggio ultraterreno della Divina Commedia), seguendo il racconto che ne ha fatto lo studioso Marco Santagata, andiamo alla scoperta della sua biografia, fra realtà, zone d’ombra e finzione letteraria.
il libro:
Da settecento anni la stella di Dante continua a brillare alta nel firmamento degli «spiriti magni» del nostro paese e della cultura occidentale. Con piglio magistrale, Marco Santagata racconta il grande poeta fiorentino attraverso le donne che egli conobbe di persona o di cui sentì parlare, e che ne accompagnarono l’intero cammino. Si avvia così un autentico carosello di figure femminili: donne di famiglia, dalla madre Bella alla moglie Gemma Donati e alla figlia Antonia, che si farà monaca col nome di Beatrice; donne amate, prima fra tutte il suo amore giovanile, la Bice Portinari trasfigurata nella Beatrice della Vita Nova e del Convivio, e poi angelicata nel Paradiso; infine le dame e le gentildonne del tempo, come Francesca da Rimini e Pia de’ Tolomei, che pure trovano voce nelle cantiche della Commedia. Lasciamoci allora guidare da parole e immagini alla scoperta anche delle zone d’ombra della biografia del poeta e vedremo dipanarsi uno straordinario, fitto garbuglio di vita vissuta e creazione letteraria.
giovedì 25 marzo

ore 21 | Mappa letteraria dei corpi contro la dittatura di Photoshop
Anatomia sensibile (Sur)
Andrés Neuman con Daria Bignardi
Con una prosa elegante e fantasiosa che si nutre di poesia, humour, esplorazione linguistica e un’intensa osservazione del mondo che ci circonda, in trenta brevi testi dedicati alle parti del corpo (dalla testa ai piedi, passando per il collo, l’ombelico e le caviglie) Andrés Neuman si ribella contro la cultura di Photoshop – contro i modelli opprimenti e i ritocchi compulsivi – e in un’epoca di iperesposizione digitale ci sprona a guardarci allo specchio e ammirare gli angoli più periferici della nostra figura, invitandoci a ripensarli sotto una luce del tutto nuova.
Anatomia sensibile è una mappa letteraria che celebra il corpo in tutte le sue forme e un tributo alla bellezza non convenzionale scritto nella forma di un viaggio poetico, politico ed erotico alla scoperta di ciò che siamo veramente. Un libro che racconta come vediamo noi stessi e come ci guardiamo attraverso gli occhi degli altri, proponendo un ideale estetico dissacrante e inclusivo che mira a scardinare i pregiudizi di genere e sull’apparenza.
lunedì 29 marzo

ore 18 | Puoi fuggire alla Storia quando ne fai parte?
Ciò che nel silenzio non tace (Einaudi)
Martina Merletti con Donatella Di Pietrantonio
1944, carcere Le Nuove di Torino. Una suora prende in braccio il bambino di una prigioniera in transito per Birkenau, lo addormenta con una pezza imbevuta di vino e riesce a portarlo fuori nel carrello della biancheria. Piú di cinquant’anni dopo una giovane donna scopre che quella vicenda la riguarda da vicino, sale in moto e decide di seguirne le tracce. A poco a poco il passato si ricompone, nonostante i molti silenzi e i numerosi depistaggi della Storia: i bombardamenti, l’occupazione nazista, lo sfollamento, gli accidenti del dopoguerra.
il libro
Agosto 1944. Una suora ribelle e coraggiosa sottrae un neonato da una cella del carcere Le Nuove di Torino facendolo scivolare nel carrello della biancheria: è il figlio di una deportata, destinato a morte certa. Si sa, la lavanderia non è affare dei tedeschi, e il piú delle volte i carrelli entrano ed escono dalle mura senza essere frugati. Ora il bambino dorme tranquillo, ma qualcuno dovrà prendersi cura di lui. Ottobre 1999. Una giovane donna sale in moto per cercare le tracce del fratello di cui fino a quel momento ha ignorato l’esistenza. La verità sul suo passato diventa una priorità che a lungo pare irraggiungibile. A unire questi due punti nel tempo è l’arco della vita di quel ragazzo sempre un po’ fuori posto, delle donne dure e forti che lo hanno salvato e accompagnato, legate dal medesimo segreto, e di un Paese lacerato e recalcitrante, che attraversa la guerra e il dopoguerra in perenne lotta con se stesso. Prendendo spunto da un fatto realmente accaduto Martina Merletti intreccia documenti e finzione, disegna figure indimenticabili, silenziose e caparbie che commuovono a ogni pagina.
lunedì 29 marzo
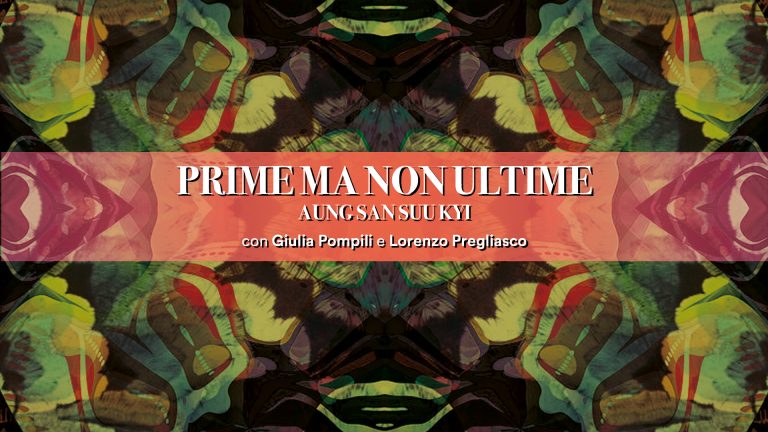
ore 21 | Prime ma non ultime #3
Aung San Suu Kyi
con Giulia Pompili, giornalista “Il Foglio” e Lorenzo Pregliasco
in collaborazione con YouTrend
Premio Nobel per la pace nel 1991, leader dell’opposizione alla guida della Lega Nazionale per la Democrazia, vincitrice delle prime elezioni libere nel 2015, arrestata nuovamente, poche settimane fa, dopo il golpe militare in Myanmar, Aung San Suu Kyi è una figura chiave per la comunità internazionale. È considerata globalmente un esempio di leadership per la democrazia e i diritti umani nel suo Paese, pur tra luci e ombre, come testimonia la controversa indifferenza verso le violenze contro la minoranza musulmana dei rohingya. La sua storia dà la possibilità di ragionare sulla complessa situazione in Myanmar, ma anche, più in generale, sul ruolo delle leadership femminili nel Continente asiatico.
martedì 30 marzo

ore 18 | L’arte delle donne dal ‘900 a oggi #3
L’arte nell’era della globalizzazione
con Luca Beatrice
Negli anni ’90 cambiano i confini geografici dell’arte, nuovi mondi spingono e contaminano il sistema con una nuova energia creativa. E le donne finalmente si impongono. Qui si parla di Cindy Sherman, Shirin Neshat, Barbara Kruger, Ghada Amer, Vanessa Beecroft, delle giovani artiste italiane e di tanto altro ancora.
mercoledì 31 marzo

ore 18 | Oltre 200 infografiche per sapere come stanno le donne nel mondo
L’atlante delle donne (add)
Joni Seager con Cathy La Torre
Questo libro rappresenta la più aggiornata e accurata analisi di come vivono le donne nel mondo. Uno scrigno di notizie e informazioni raccontate in oltre 200 coloratissime e ricche infografiche che descrivono desideri e volontà di cambiamento delle donne nel mondo. Pagina dopo pagina si scoprono notizie sulle violenze domestiche, sul numero di figli per donna, sull’accesso alla contraccezione, sulla salute femminile, sul mondo del lavoro, sull’istruzione delle ragazze, sull’alfabetizzazione informatica, sulla presenza di donne negli organi di potere. E si incontrano verità sorprendenti come che nel 2018 l’Islanda è stata la prima nazione a rendere illegale il divario retributivo di genere. O che il 40% delle donne sudafricane nella vita subirà una violenza. Che è stato il Ruanda il primo Paese a eleggere un governo a maggioranza femminile. Che, oggi, 520 milioni di donne non sanno leggere. Aggiornato con gli ultimi dati disponibili, L’atlante delle donne svela un mondo diverso da quello che vogliamo credere sia, diventando uno strumento necessario per affrontare i temi sempre più urgenti dell’uguaglianza di genere.
mercoledì 7 aprile
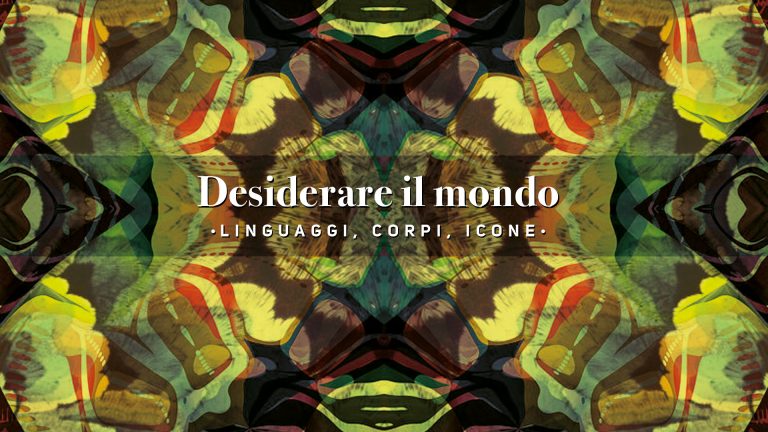
ore 21 | Manifesto per un eros politico e rivoluzionario
Il capitale amoroso (Bompiani)
Jennifer Guerra
Mentre il nostro immaginario è infarcito di amore – una versione romantica e fasulla, veicolata da romanzi, film e pubblicità -, la nostra società si comporta come un amante dal cuore spezzato: è cinica e sprezzante nei confronti dell’amore, considerato un sentimento stupido, inutile o noioso, una fantasia per adolescenti, un ripiego per chi non sa stare solo, un lusso per pochi. Questa contronarrazione è il frutto pericoloso dell’individualismo capitalista, un sistema che mentre stigmatizza la solitudine e colpevolizza chi la vive come indegno d’amore, ci vuole sempre più soli, divisi e in competizione fra noi. Concentrati su noi stessi, ci vediamo rubare il tempo che potremmo usare per coltivare le relazioni con gli altri, amore compreso. Ma il rimedio a questa crisi dell’amore esiste. Nell’epoca in cui le relazioni si basano sullo scambio, sull’utilità, sulla convenienza, sulla compatibilità, lasciare spazio invece a un amore incondizionato e libero, capace di passare dal singolo alla comunità, può essere una delle azioni più antisistema, rivoluzionarie e coraggiose che possiamo fare per cambiare la nostra società: un vero atto di resistenza in questi tempi sempre più divisi.
SPAZIO AI BAMBINI sul canale YouTube dal 1 marzo
Mitiche. Storie di donne della mitologia greca(La Nuova Frontiera Junior)
Penelope, Pandora, Arianna e Aracne
con Giulia Caminito
A partire dal libro edito da La Nuova Frontiera Junior (di Giulia Caminito, illustrato da Daniela Tieni) Giulia Caminito traccia i ritratti inediti di quattro figure femminili rese immortali dalla letteratura: Penelope, Pandora, Arianna e Aracne.
MUSA e GETTA
Musa e getta. Sedici scrittrici per sedici donne indimenticabili ma a volte dimenticate (Ponte alle Grazie)
a cura di Arianna Ninchi e Silvia Siravo
Per il tempo di un concerto o per una vita, hanno stretto relazioni complesse (e pericolose) con uomini importanti e al centro dell’attenzione. E se mettessimo finalmente loro al centro dell’attenzione? Se ci chiedessimo chi si nasconde dietro al bellissimo volto di donna immortalato in quel celebre quadro? O come ha vissuto la scienziata che non è stata premiata? Sedici scrittrici tra le più significative del panorama italiano indagano su sedici donne che sono state muse, ma oggi sono pronte a mostrare il loro talento al lettore. Sedici corpi che non hanno più paura della loro ombra.
I video saranno disponibili su IGTV del Circolo dei lettori
Ritanna Armeni racconta Nadia Krupskaja
Angela Bubba racconta Maria Callas
Maria Grazia Calandrone racconta Amanda Lear
Elisa Casseri racconta Pamela des Barres
Claudia Durastanti racconta Alene Lee
Ilaria Gaspari racconta Jeanne Hébuterne
Lisa Ginzburg racconta Lou von Salomé
Cristina Marconi racconta Zelda Fitzgerald
Lorenza Pieri racconta Kiki de Montparnasse
Laura Pugno racconta Sabine Spielrein
Veronica Raimo racconta Regine Olsen
Tea Ranno racconta Luisa Baccara
Igiaba Scego racconta Laure
Anna Siccardi racconta Dora Maar
Chiara Tagliaferri racconta Kate Moss
GRUPPI DI LETTURA EXTRA
Tutti gli incontri sono online in diretta e on demand
Link prenotazione
Mercoledì 3-10-17-24/03 h 19-20
Margaret Atwood: distopie e femminismo consapevole
con Loredana Lipperini
in collaborazione con Ponte alle Grazie
Raccontare il futuro per parlare del presente
La Atwood ci mette davanti realtà dure e sgradevoli, talmente terrificanti che non ci sembrano poi così tanto lontane e improbabili. Perché ha la capacità di aprirci gli occhi sul presente parlando di futuro, di uno dei tanti futuri possibili, e quindi vicinissimi. Parlando soprattutto dei silenzi, di parole e azioni, a cui sono costrette le donne. In quattro incontri ripercorriamo le sue fantasie narrative per conoscere meglio quello che potremmo essere, o siamo già.
Martedì 16-23-30/03, 6/04 h 18-19
Shirley Jackson: un’icona da incubo
con Silvia Pareschi e Simona Vinci
in collaborazione con Adelphi editore
Al confine tra normalità e follia con la maestra dell’horror
«Finiscono con una svolta che ti porta dritto in un vicolo buio», così scriveva Shirley Jackson delle sue storie. E il vicolo buio è quello delle nostre paure, che, leggendo la musa ispiratrice di Stephen King, vengono costantemente portate in superficie, risvegliate. Silvia Pareschi e Simona Vinci, due delle sue traduttrici italiane, ci conducono alla scoperta dei generi, gli stili e le opere dell’autrice icona della fiaba gotica del XX secolo. Ripercorrendone romanzi e racconti, ci immergiamo nelle atmosfere del thriller nero e nel clima surreale e straniante di una scrittura al confine tra normalità e follia.
Programma in costante aggiornamento su circololettori.it